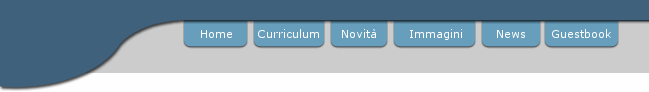|
|
Stefano De Rosa su "Un paese ci vuole"
“Un paese ci vuole” di Federico Solfaroli Camillocci induce all’ascolto e alla riflessione
MONTEREALE: UNA COMBRAY DEI NOSTRI GIORNI
La memoria è necessaria? Ha ancora senso nel Terzo Millennio coltivare le proprie radici storico-culturali? L’istituto familiare con la sua fitta rete di affetti e relazioni è un patrimonio da tutelare? A queste domande, Federico Solfaroli Camillocci con il suo libro “Un paese ci vuole” – edito nel 2008 dall’Istituto di Abbruzzesistica e Dialettologia, pagg. 110 – fornisce una convincente risposta suffragata da un favorevole angolo visuale.
Il paese di cui l’Autore parla è, infatti, Montereale, in provincia dell’Aquila, suo luogo di nascita. Ma non si tratta soltanto di quel privilegiato riferimento topografico che custodisce l’humus di sensibilità e di affetti che lo ha nutrito nell’età dell’infanzia; è piuttosto un luogo dell’anima, un rifugio protetto dove ad essere serbati con cura sono ricordi e valori vieppiù aggrediti da una quotidianità arrogante ed invasiva che erode senza riguardo i tempi e gli spazi di ognuno.
Il “paese” di Solfaroli Camillocci, con mirabile sdoppiamento tra reale ed immaginario, è, allora, non solo la chiesa e la piazza, la casa e la scuola, ma è da intendere come un modello da perseguire, l’oggetto della costante ricerca di un ideale di solidarietà conosciuta ed ora dispersa, di socialità nuova ed antica verso cui tendere.
La costante dialettica presente-passato che contraddistingue lo stile della narrazione avvolge il lettore in un gioco di specchi riflessi dove il parallelo e complice dialogo tra l’io narrante e il noi viene coniugato da valori condivisi e dove il tu di chi non ha il paese dentro di sé non significa esclusione, bensì desiderio di inclusione, senza, tuttavia, sacrificare valori identitari e comunitari sull’altare di facili, innaturali integrazioni. Ed è proprio grazie a questi specchi che l’altrove – in virtù di un paradosso solo apparente – diventa l’alleato più prezioso di ciò che fa il paese della propria intima declinazione.
I brevi, garbati profili di familiari ed avi tratteggiati con abili, ma decise pennellate dall’Autore testimoniano la feconda interpenetrazione di esperienze personali e generazionali che affondano le proprie radici nei ricordi sedimentati dal tempo. Un fitto ordito di relazioni dal quale le generazioni che hanno preceduto quella attuale hanno tratto beneficio, saggezza e spiritualità. Il merito che intendiamo riconoscere a Federico Solfaroli Camillocci non attiene solo alla sua pregevole opera, ma comprende la pluralità di stati d’animo che l’Autore, con la sua prosa e le sue riflessioni, riesce a suscitare nel lettore.
L’agilità della lettura, infatti, si fonde straordinariamente con la profondità delle pagine che attingono ai giacimenti reconditi della memoria. Di inno all’autunno, si può parlare. A quella splendida stagione che non appartiene a tutti, ma solo a chi dispone di quell’outillage mental per goderne la voluttà dei colori e la sua avvolgente decadenza.
Chiunque, con l’irruzione del proprio “vissuto” nella dimensione geo-temporale, riscontri affinità autobiografiche in queste pagine, può decidere – ci perdonerà l’Autore – cosa sia paese e cosa non possa esserlo. Cosa possa nobilmente fregiarsi di un titolo in grado di sancire la sacra unione di Terra e Sangue e cosa sia, invece, destinato ad essere relegato nelle anguste periferie del non-paese. È forse un azzardo, scomodando Proust, parlare di una Combray dei nostri giorni, di un luogo di una memoria mai tradita e sempre ritrovata? Al lettore stabilirlo e ad esso decidere se “Un paese ci vuole”.
Il libro può essere richiesto direttamente all’Autore visitando il sito www.solfaroli.it.
Stefano De Rosa
|
|
| |
|
|
Il mio libro "Un paese ci vuole"
“Làsciati portare dal ragazzo che sei stato”
Gli uomini cercheranno sempre di condividere con altri le loro esperienze più profonde. Anche per questo nascono i libri.
Ha scritto il pittore Ennio Morlotti: “L’unico contributo che posso dare ai miei simili è quello di raggiungere il punto più alto delle mie emozioni”.
Scrivere, come dipingere, come comporre musica, è raccontare emozioni.
Il mio libro è una raccolta di quadri narrativi, di tanti istanti di meraviglia quali solo il rapporto con i luoghi dell’anima e la natura ci sanno offrire.
Come ha osservato Claudio Magris, “questa costruzione per schegge, per frammenti, apparentemente dispersi ma tendente a formare un tutto, è un modo di vivere e sentire il mondo, prima ancora che di scrivere.”
Molto, nelle nostre vite, resta asimmetrico, incompiuto, contraddittorio. Difficile dare un senso coerente al tutto.
La mia idea di scrittura è quella di una prosa che procede per illuminazioni, per intuizioni, che sconfina spesso nella poesia: l’intuito supremo è quello del poeta, amava ripetere Francesco Biamonti. Una prosa dove lo sguardo sulla realtà si riduce sempre a un guardare dentro se stessi, secondo un’idea dello scrittore veneto Giovanni Comisso, secondo il quale narrativamente non esiste che la storia di se stesso.
La scrittura è allo stesso tempo un soliloquio e un colloquio. Consente di parlare a se stesso e agli altri. La scrittura serve a salvare qualcosa della nostra vita, a mettere ordine nelle nostre ossessioni, a comunicare con gli altri.
Al centro del mio racconto c’è l’esperienza delle origini.
Io – come molti della mia generazione - non ho avuto un’infanzia metropolitana.
I luoghi della nascita e degli anni dell’apprendimento “emettono – osserva Olivier Rolin - qualcosa di paragonabile a una radiazione fossile, una sorta di firma dell’origine”.
Il mio rapporto con il paese delle radici non è, tuttavia, un rapporto nostalgico, né idilliaco. E’ un rapporto contraddittorio; da un lato si sente forte il bisogno di ancorarsi a qualcosa, dall’altra si avverte un istinto di libertà, di fuga, di ricerca di orizzonti più ampi. In questo senso, il rapporto col paese è una metafora di una condizione umana più generale, in bilico tra esigenze di certezze e bisogno di fuga.
E’ un libro sui ricordi. “Noi siamo quello che ricordiamo. Il racconto è ricordo e il ricordo è vivere” diceva Mario Luzi. In questo senso è vero che la vita non è quella che abbiamo vissuta, ma quella che ricordiamo. L’importanza della memoria è tutta condensata in una frase di Andrea Tarkovskij: “un uomo privo della memoria è in balia di un’esistenza illusoria”.
Vedere le cose è ri-vederle, conoscerle è ri-conoscerle.
Il paese è il luogo dove abbiamo visto le cose per la prima volta. E’ anche il depositario di valori antichi. Rapporti umani più diretti, una cadenza della vita diversa, regolata sui ritmi della natura, una parsimonia nel vivere, un rapporto diverso con gli oggetti, visti come cose destinate a durare piuttosto che al consumo.
Il paese è il luogo in cui il silenzio dà respiro al nostro pensiero, è il luogo in cui la noia diventa una virtù, che consente di liberarci dalla calca degli avvenimenti che in città premono sui nostri ritmi di vita.
C’è probabilmente un paese nella vita di tutti, anche di chi non vi è nato. Per questo l’esperienza che racconto è riconoscibile da parte di molti di noi. Il paese in questa caso si chiama Montereale, ma potrebbe chiamarsi in altro modo. Le mie pagine sono fortemente innervate nella terra abruzzese. Ma quello che avviene nei paesi ha un denominatore comune.
Oggi per tanti paesi esiste il rischio dell’estinzione. Si parla di paesi della bandiera bianca, di paesi che si arrendono. Forse li salverà l’immigrazione o internet o forse noi torneremo indietro a popolarli come un tempo.
Il mio è anche un libro sulla necessità della poesia, sul camminare come forma di conoscenza, sulle virtù della solitudine, sul valore della contemplazione del paesaggio, sull’attrazione che la natura esercita sulla psiche umana, sulla ricerca di una intesa intima, direi carnale, tra l’uomo e la terra.
La natura – scrive Edward Wilson - evoca in noi emozioni ancestrali. Sono emozioni che assomigliano ai ricordi e alle esperienze di un bambino: possono essere percepite, ma di rado riusciamo ad esprimerle. Ci provano i poeti. I poeti riconoscono che qualcosa di fondamentale si muove nel nostro inconscio, qualcosa che merita di essere conservato.
Il libro della natura riesce a darci un alfabeto di valori che può essere un antidoto allo smarrimento generale.
C’è nel mio libro una ricerca costante, direi accanita, se non disperata, di ciò che è bello, di ciò che dà piacere. Forse è una inconsapevole ribellione alle cose tristi della vita: l’ossessione del trascorrere del tempo, che tutto polverizza, l’indifferenza umana, la fine degli affetti, la distruzione del paesaggio, la crudeltà della malattia. Non posso vivere fuori della bellezza, scriveva Camus.
Un brano del libro a cui tengo molto è “Occhi di ragazza”. Lì c’è non solo la scoperta della bellezza, dell’attrazione misteriosa che si svela all’improvviso dopo anni di inconsapevolezza; c’è soprattutto il gioco del destino, un destino che non cala dall’alto, come un qualcosa di determinato da una forza superiore; è un destino che esiste anzitutto nella nostra mente, che noi contribuiamo a formare. Il destino è ciò che noi siamo o anche ciò che non siamo capaci di essere. Il destino dà le carte, ma siamo noi a giocare. Se c’è una forza esterna che condiziona le nostre vite, piuttosto è il Caso.
In un altro brano del libro, “Cespugli di more”, il tema è, invece, quello dei ricordi che si incarnano nei luoghi. Esistono luoghi privilegiati che evocano situazioni passate, stagioni della nostra vita, stagioni dell’anno.
A molti piace “La prima discesa”. E’ la pagina “futurista” del libro, tutta energia, velocità, amore per la montagna.
Ma il brano che sintetizza i diversi temi del libro è probabilmente “Ad ogni ritorno”. Lì è condensato il senso del legame profondo con il paese di nascita, l’emozione del ritorno, l’importanza del contatto con la natura, il sapore speciale dei rapporti con la gente del luogo.
Vorrei concludere con le parole di un poeta ligure del Novecento, Camillo Sbarbaro, che bene si addicono a questi temi.
“S’affacciano questi ricordi,
senza ragione,
dolci così che non paiono veri –
nella mia vita arsa,
erba
che si ostina
nel lastricato della città”.
|
|
| |
|
|
Alberi
“… Ormai, se qualcuno invidio, è l’albero.
Freschezza e innocenza dell’albero! Cresce a suo modo.
Schietto, sereno. Il sole, l’acqua lo toccano in ogni foglia.
Perennemente ventilato.
Tremolio, brillare del fogliame come un linguaggio
Sommesso e persuasivo!
Più che d’uomini, ho in mente fisionomie d’alberi.
Ci sono alberi scapigliati ed alberi raccolti come mani
Che pregano. Alberi che sono delicate trine sciorinate;
altri, come ceri pasquali.
Alberi patriarcali, vasti come case, rotti dalla fatica di
Spremere per generazioni la dolcezza dei frutti.
C’è albero di città, grido del verde, unica cosa ingenua
Nel deserto atroce.
Ma più di ogni altro, due alberi ricordo, che crescevano
Da un greto di torrente, allato, come svelti fratelli …
Essere un albero, un comune albero …”.
(Camillo Sbarbaro)
Ho letto di un uomo, nato in Danimarca e trasferitosi per lavoro in Groenlandia, terra notoriamente coperta di neve e ghiaccio, il quale, quando torna a casa, ama toccare gli alberi, ne accarezza la corteccia, abbraccia il tronco. Vivere in una terra senza boschi deve essere davvero inusuale. Ci deve sentire più soli, più vulnerabili.
L’albero ci trasmette calore. Come ogni essere vivente, ha una sua dimora e una sua vita, nasce cresce e muore, proprio come noi. Toccandolo sembra di sentire il suo respiro, la sua forza, la sua saggezza, persino la sua sofferenza, se è soffocato dall’asfalto o vittima di malattie.
“Gli alberi sono come noi - scrive Mauro Corona - e noi siamo come alberi, ognuno con il proprio carattere, struttura fisica, fortuna e disgrazia. Osservando le piante, tutti ci possiamo riconoscere nell’una o nell’altra perché anch’esse, come noi, possiedono una personalità, un modo di vivere, un’educazione, una cultura.”
Si trovano, nelle nostre campagne, esemplari di noce che emanano un senso di robustezza e di saldezza incomparabile, non inferiore a quello proverbiale della quercia.
I cerri, che coprono gran parte del nostro territorio, in autunno si ammantano del color ruggine delle loro foglie, mentre a terra si depositano le ghiande che un tempo nutrivano i maiali.
Nel giardino di casa, mi fermo spesso ad accarezzare la bianca corteccia della betulla o quella grigia dei tigli.
La costeriana che troneggia nel prato ha segnato il passare degli ultimi anni. Da fragile alberello è diventata un imponente monumento naturale che gareggia in altezza con la casa.
In primavera spiccano tra gli arbusti a lato della strada i fiori gialli del maggiociondolo, specie molto diffusa in Abruzzo, insieme alla robinia e al nocciolo.
Se c’è, tuttavia, una specie che mi riporta all’infanzia è il ciliegio. Sorgeva un bel ciliegio su un terreno di mio nonno lungo la strada per L’Aquila, dove andavamo da piccoli a cogliere i frutti. Ci andavo con i cugini, allegri e vocianti. Lì vicino sorgeva il casale che un tempo era di mio nonno. Per anni gli affittuari ci consentirono di entrare e giocare sull’erba. Fuori del rudere, appoggiata al muro, vi era una vasca da bagno, usata forse per raccogliere l’acqua come abbeveratoio delle bestie; ricorda Paola che spesso mi introducevo nella vasca e, come fosse la pedana di un palcoscenico, prendevo a cantare mimando Celentano.
D’estate qualcuno si arrampicava sul ciliegio per cogliere i frutti più alti. Una volta un ramo si spezzò sotto il peso di mio padre che vi era salito, con la sua consueta generosità, per soddisfare i desideri di noi piccoli.
Con nostalgia ricordo pure gli alberi di mele, pieni di frutti dal sapore unico e genuino, che furtivamente coglievamo nei lunghi pomeriggi estivi. E le acacie – con le foglie costruivamo una sorta di pipa – e i castagni.
Sì, si può provare nostalgia di un albero, come di una persona, come di un luogo, come di un tempo.
|
|
| |
|
|
La prima discesa
La prima discesa, la migliore.
Sbarco dalla funivia in cima al Pratello nel vento freddo del primo mattino. Dalla spalla lascio cadere gli sci sulla neve dura. Stringo scarponi e attacchi accuratamente, poi rialzo la testa e guardo intorno.
Sono solo, splendidamente solo. Davanti a me un universo bianco di neve e nuvole. E silenzio.
Da quassù, nel cuore dell’Appennino, vedo tutti i monti dell’Abruzzo: a nord, il Gran Sasso, con la punta protesa verso il versante adriatico; a destra, a due passi, la Maiella, tonda, calva, monacale; a ovest, affondato nella neve, l’altopiano oltre il quale sorge Scanno. Sotto le Cinque Miglia, un mare di nuvole, illuminato dal sole, copre Sulmona.
La pista, verso il basso, è un’autostrada perfettamente battuta, una distesa vergine, che chiede a gran voce di essere solcata.
Fremente, mi do una spinta e mi lancio nella discesa, prima con cautela, poi sempre più velocemente. Le orecchie sono piene del vibrare delle lamine che, come rasoi, solcano quel tappeto di ghiaccio.
Si va che è una bellezza. Che spettacolo, tutto quel ben di Dio candido e pulito è a mia completa disposizione, senza interferenze, senza ostacoli.
Disegno curve ampie e poi strette. Accarezzo il compatto pavimento di neve, godendo di una gioia tutta mia. Scivolo fluido e libero mentre il fragore degli sci mi dà la misura dell’andatura.
I muscoli delle gambe si tendono, si scaldano, cominciano a tirare. Allento la presa, mi lascio andare.
Vado giù, macinando metro su metro, mi sento padrone del corpo e della pista. Ad ogni curva un senso di piacere e dopo di essa la nostalgia di un attimo prima.
Così consumo, rapidamente, la prima discesa, contro ogni prudente cautela. Poi la seconda, e una terza, con la stessa frenetica ansia di bruciare piacere, energia, spirito, materia; io, solo, con le mie montagne.
Dopo due ore sono appagato. Ho avuto il meglio, ciò che cercavo. Ora la montagna può anche concedersi alla folla degli sciatori.
|
|
| |
|
|
La forza dei ricordi
Rivedere i luoghi dell’infanzia ingenera nostalgia. La nostalgia ci induce a pensare ai tempi passati come ai più belli, li rimpiangiamo. In realtà, non è poi così scontato che allora fossimo più felici o migliori di oggi: semplicemente quei tempi sono passati. E ciò provoca appunto nostalgia.
Essere assaliti dai ricordi, quando si torna al paese d’estate, è un fenomeno naturale, che si rinnova puntualmente. Soprattutto l’estate è, per molti di noi, la stagione alla quale sono legati i ricordi del paese.
Ha scritto il regista Ermanno Olmi: “I ricordi hanno una loro vita e una loro forza che spesso supera la nostra stessa volontà. Siamo noi ad appartenere ai nostri ricordi più che loro ad appartenere a noi.”
E’ vero, sovente i ricordi ci rapiscono, si impossessano di noi. Basta la percezione di un odore o la vista di un luogo particolare – un muretto, un portone, un angolo di strada – per riportarci indietro negli anni.
In quell’universo complesso che è la nostra mente si scatena così un susseguirsi di immagini e di sensazioni, fino ad allora avvolte nella ragnatela del tempo, sedimentate in noi, e che tornano nuovamente alla luce.
Non so se il riaffiorare dei ricordi, e la gioia che provoca il ritorno nei luoghi natii, provengano effettivamente dalla nostra mente, o se è piuttosto il luogo che parla di sè.
Sta di fatto che, tornando in paese, ho la consapevolezza che lì sono avvenuti i miei primi contatti col mondo. Un certo modo di vedere le cose, una certa sensibilità si sono formati in quei luoghi, che hanno dato al nostro cervello una specie di imprinting.
Mi capita ancora oggi, nell’osservare talune tonalità di azzurro del cielo o particolari tipi di nuvole, di avere l’impressione che quelle immagini siano già depositate nella memoria. Solo tornando nei luoghi natii, comprendo che sono i cieli delle lontane estati a Montereale.
In questo senso, il paese vive in noi, e ci accompagna ovunque, anche quando ne siamo lontani.
|
|
| |
|
|
Provenza
A Ménerbes nell’aria risuona soltanto il rumore del vento che penetra nelle vie strette del paese, accarezzando i muri in pietra.
Qui, nel cuore verde del Lubéron, incontriamo finalmente la Provenza che cercavamo, la Provenza dei vigneti, delle abbazie, dei poeti.
Nel caldo pomeriggio di una domenica di inizio settembre, sotto un cielo blu cobalto, questo borgo silenzioso ci offre tutta la sua calma riposante.
Dimore di due o tre piani - ricche di dignità, curate e ben tenute da proprietari che dimostrano quanto si possa amare questo luogo, che sembra sospeso nel tempo - sorgono attorno al palazzo municipale, a una piazza deserta e a una chiesa dalla facciata essenziale e austera.
Lo attraversiamo, sbigottiti da tale bellezza semplice e intatta, fino alla punta finale dello sperone di roccia su cui è posto il paese, occupato da un antico cimitero di poche lapidi abbandonate, proteso verso la luminosa valle sottostante.
Da un arco, che si apre nel muro di un palazzo, lo sguardo dilaga nella verde campagna, ricamata dalle coltivazioni regolari e floride, fino all’estremo opposto della vallata dove, oltre la linea delle colline, si intravede la linea tonda di roccia bianca dei monti su cui camminò il Petrarca.
Oltre che per l’amenità del luogo e il sapore di antico che vi aleggia, Ménerbes ci appare bello perché resta lontano dalle file di turisti che affollano la Provenza.
Siamo giunti qui al termine di una giornata trascorsa in auto alla ricerca della Provenza più autentica, quella che non esiste più a Le Baux o in altri splendidi centri della regione.
Ovunque ci sorprende la perfezione di tanti paesi sconosciuti che attraversiamo. Una compostezza, una omogeneità nelle costruzioni, nei disegni delle case e delle strade, che vorremmo vedere preservata anche in Italia.
Lasciata l’autostrada a Cavaillon, siamo saliti verso Gordes, arroccato su uno spuntone di roccia che guarda da nord la valle, abbiamo visitato il villaggio di “bories” – antiche costruzioni in pietra a secco, che ricordano un po’ certi manufatti dei pastori abruzzesi e un po’ lo scenario dei Sassi di Matera – e la maestosa abbazia di Senanque.
La sosta del pranzo è avvenuta in un piacevole ristorante nel verde del fondovalle, dove abbiamo apprezzato una raffinata cucina provenzale a base di paté di acciughe, carne farcita, pesce e dessert alla frutta. Sulle tovaglie in carta sono impressi i versi del poeta Frédéric Mistral, in tre lingue, provenzale, francese e inglese. Nel chiederne un esemplare come souvenir, prometto alle giovani cameriere, dal dolce sorriso che sa di campagna, che tradurrò quelle parole in italiano.
“Mieterò a piene mani
raggi e sogni:
poi lancerò sul tuo tavolo
una pioggia di stelle.”
Da “estello”, il provenzale per stella, il nome del ristorante: “L’Estellan”.
Quindi, tra filari bassi di viti, raggiungiamo il colle ove sorge Roussillon, noto per il percorso dell’ocra, che si sviluppa su un terreno polveroso dai colori magici, dall’arancione al rosso, dal ruggine al marrone, che emergono da una vegetazione tipicamente mediterranea. Percorriamo, poi, il lato meridionale della valle, toccando Bonnieux e infine Ménerbes, in un crescendo di campagna leggiadra e suggestiva, che Peter Mayle scelse come dimora ambientandovi il libro “Un anno in Provenza”.
Se Ménerbes è il paese che più ha accesso la nostra immaginazione, Arles è senza dubbio la città della Provenza che più ci ha lasciato un sapore di dolcezza. E’ una città che conserva una sua forte autenticità, non intaccata dal flusso turistico. La pervade un forte senso della storia e di socialità. La vista sul fiume Rodano, dagli argini alti in pietra, fa impressione. Il fiume qui è imponente nella sua portata, ormai vicino al mare. Questo forse ci lascia anche una sensazione di essere in una città di mare, di porti, di passaggio di genti.
Vagando per le viuzze della città, dopo aver visitato il magnifico chiostro della cattedrale, giungiamo per caso davanti a una libreria, graziosa e ben fornita, dove l’odore di carta si mescola a quello di legno degli scaffali.
Nei pressi di Arles seguiamo le indicazioni per il ponte di Langlois, chiamato ponte Van Gogh, perché immortalato dal pittore che visse nella città provenzale. Facciamo appena in tempo ad osservare il ponte quando un pullman scarica sul posto un gruppo di giapponesi che si precipita silenzioso a scattare fotografie. Fu il regista giapponese Kurosawa a dedicare al quadro di Van Gogh un’immagine geniale ed emozionante in un episodio del film “Sogni”: la scena raffigurata dal pittore olandese prende vita all’improvviso, portandoci magicamente nel mondo di allora.
Anche Aix ha un suo fascino, sebbene la massiccia presenza turistica sembri sovrabbondante rispetto alle strette vie della città, che ci ricordano certi quartieri di Parigi. Accade che di giorno la vediamo brulicare di gruppi di pensionati in coda per ammirare Cézanne, di cui ricorre il centenario dalla morte, mentre di sera il centro assume il volto giovani degli universitari che popolano i tavolini dei bar nelle strade e nella piazze.
Non può mancare una gita verso il Monte Sainte Victoire, il cui nome è legato indissolubilmente a Cézanne. Lo scorgiamo tra la bella vegetazione salendo verso Le Tholonet. La giornata è calda e la luce non è delle più favorevoli a causa di una densa foschia. Riusciamo comunque ad ammirare l’imponenza della roccia grigia del massiccio ossessivamente ritratto da Cézanne. Proseguiamo quindi tra pendii brulli e deserti, fino a intraprendere il giro completo attorno al gruppo montuoso che ci porterà tra vigneti sconfinati e poi tra boschi bassi e selvaggi fino a Vauvenargues, dominata dal castello ove visse e riposa Picasso, quindi nuovamente ad Aix.
Abbiamo percorso tanti chilometri, conoscendo luoghi suggestivi. Lasciamo la Provenza con l’idea di tornarci non più soltanto per vederla, ma per viverla.
|
|
| |
|
|
Un mistico senza Dio
Un mistico senza Dio, così lo ha definito qualcuno. Il nome di Albert Camus, scrittore franco-algerino, morto nel 1960 a soli 47 anni, è noto ai più per “La peste”.
Per quanto mi riguarda, mi identifico nelle pagine di “Nozze”, “L’estate”, e, infine, dei suoi “Taccuini”, che raccolgono appunti e impressioni annotate in forma di diario e in parte rifluiti nelle sue opere.
In alcune righe emerge il profilo mistico del pensiero di Camus, la sua visione del rapporto profondo, fisico, carnale tra l’uomo e la terra (le “Nozze” cui allude il titolo di una sua opera non sono altro che l’incontro intimo tra noi e la terra).
A Fiesole, nel chiostro di San Francesco, “un cortiletto cinto da arcate e traboccante di fiori rossi, di sole, di api gialle e nere”, Camus comprende le fonti di ispirazione dei francescani e sente che “se hanno ragione, hanno ragione con me”.
Qui, oltre un muretto, si mostra alla vista la collina e, in basso, tutta Firenze. “Questo splendore della natura è la giustificazione di quegli uomini, (…) di tutti quegli uomini della mia razza, i quali sanno che l’estremo della povertà si confonde sempre col lusso e la ricchezza del mondo”; “se si spogliano lo fanno per una vita più grande (non per un’altra)”.
Questo “accordo fra la mano e i fiori, questa intesa amorosa fra la terra e l’uomo scioltosi dall’umano … ah, come mi convertirei volentieri, se non fosse già la mia religione!”.
“… Non ho altra forza che di amare e ammirare”, annota Camus, quasi a voler riassumere in queste due parole il senso ultimo e autentico dell’esistenza, la sua intima missione.
Nei suoi ultimi anni di vita, si moltiplicano i viaggi in Grecia, la terra in cui sono nati il mito e il pensiero fondante dell’Occidente. I suoi appunti di viaggio sono un susseguirsi di osservazioni sui luoghi della storia e della natura. Quando giunge a Corinto, scoppia l’ammirazione della costa del golfo: “Una luce danzante, aerea, giubilante, inonda il golfo e le isole al largo. Ci fermiamo un momento sul bordo della scogliera e tutta l’immensità del mare è davanti a noi, offerta in un’unica curva, come una coppa da cui beviamo luce e aria, a lunghi sorsi. Dopo un’ora di viaggio, sono letteralmente ubriaco di luce, ho la testa piena di esplosioni e di grida silenziose, e nell’antro del cuore una gioia enorme, una risata interminabile, quella della conoscenza.”
Nello stupore per la bellezza, nell’incontro fisico rivelatore tra la terra e l’uomo, tra il mondo meraviglioso che ci circonda e la ragione profonda del nostro essere sta, a mio avviso, l’originalità e la forza del pensiero di Camus.
|
|
| |
|
|
Notte sull'altopiano
La notte invernale è scesa da poco sull’Altopiano delle Cinquemiglia.
Nel buio delle tenebre risalta il bianco dei campi di neve, illuminati dal chiarore della luna.
La strada corre dritta e facile attraverso quel paesaggio in bianco e nero.
Nel cielo la fa da padrona la luna piena, inseguita da mille stelle che sembrano invidiarla per quella luce abbondante. Lei ci guarda, bella tonda, coi suoi occhi quasi imploranti e una smorfia della bocca.
Così doveva essere un tempo la notte. Così dovevano viverla i pastori dell’altopiano.
Lontano, oltre il crinale delle montagne intravedo il grigio di nubi stanche.
Domani sarà un giorno luminoso e freddo.
|
|
| |
|
|
La stagione dell'anima
All’alba del 2 gennaio Rivisondoli è ancora immersa nel sonno quando esco di casa per tornare a Roma col pullman. Se non fosse per il fumo che si alza dai camini, si direbbe un paese morto e abbandonato. L’unica luce accesa è quella del fornaio. Il profumo del pane in cottura mi avvolge appena sono sull’uscio, dandomi un piacevole senso di calore e familiarità.
Il cielo inizia lentamente a schiarirsi nel nascere di un giorno che sarà freddo e terso.
Il ghiaccio notturno ricopre le strade, trasformate in specchi ove si riflettono le luci dei lampioni.
Sulle vie si pattina e anche l’autista del pullman procede con cautela.
Roccaraso, Pettorano sul Gizio, Sulmona e quindi in autostrada.
Ora la dimensione muta. Mi lascio alle spalle la poesia per tornare alla quotidianità.
Al ritorno in paese, il 5 gennaio, il paesaggio è fatato. Le abbondanti nevicate dei giorni precedenti hanno ricoperto ogni cosa di neve soffice.
E’ tardo pomeriggio quando giungo ai piedi del paese, proprio mentre si svolge la rappresentazione del Presepe vivente, che non potrebbe ambientarsi in una cornice più suggestiva. Le torce dei pastorelli e dei Re Magi illuminano il biancore del manto nevoso, in cui gli attori a cavallo vanno e vengono intorno alla capanna.
L’indomani lo scenario è fiabesco: l’azzurro perfetto del cielo esalta il candore dei campi e dei tetti. Gli alberi sono gonfi di neve, che a stento trattengono. Da lontano, l’effetto è quello di un velo di zucchero soffiato sulle chiome dei faggi. Davvero la neve è un fenomeno magico della natura.
La chiamiamo la “brutta” stagione. Invece, diceva bene uno scrittore: l’inverno è la stagione dell’anima.
|
|
| |
|
|
Amati scrittori
Il libro parla solo di se stesso e non di chi lo ha scritto. Così sostiene un’interpretazione.
Questa idea non mi convince.
Non riesco, infatti, a non vedere riflesse, nelle pagine di tanti amati scrittori, l’interiorità e le esperienze reali di persone che hanno trovato nella scrittura lo svuotamento della loro natura più intima.
Come non rintracciare, ad esempio, nella voce narrante di La spiaggia di Cesare Pavese i tratti caratteristici di un uomo così soffertamente oscillante tra tendenza all’isolamento e bisogno di non sentirsi solo, la sua impazienza verso le contraddizioni dei comportamenti umani.
Come non ricondurre all’uomo-Goffredo Parise quel fondo di struggente malinconia esistenziale, quella dolorosa nostalgia per la vita che fugge, che pervadono i suoi Sillabari.
Come non percepire come esperienza vissuta in prima persona l’incantamento che suscita la donna amata nell’animo del protagonista di Una questione privata di Beppe Fenoglio.
Accostandoci alla prosa sontuosa di uomini che hanno interpretato la vita liricamente, siamo inevitabilmente portati a scavare nelle loro vicende esistenziali, per comprendere più a fondo da dove esattamente provenga tanta sensibilità, tanta intuizione, tanta irrequietezza.
Le voci di questi ed altri scrittori contemporanei restano stampate sulla carta. Leggendole e rileggendole, ci illudiamo di continuare a parlare con loro, rimpiangendo di non averli conosciuti.
|
|
| |
|
|
I conquistatori del Gran Sasso
“Il vero montanaro è un vagabondo e per vagabondo (…) intendo un uomo che ami andare ove mai uomo sia stato prima di lui, che impiega il suo piacere ad incollarsi a rocce che non abbiano mai sentito il tocco di dita umane, o a tagliarsi la strada in canaloni di ghiaccio le cui ombre torve sono il soggiorno sacro delle nubi e delle valanghe dal dì in cui la Terra è uscita dal caos. In altre parole il vero montanaro è l’uomo che tenta nuove ascensioni. Non importa se vi riesce o no; egli ricava il suo piacere dalla fantasia o dal gioco della lotta”.
A queste parole di Albert F. Mummery ho ripensato leggendo il bellissimo libro di Marco Dell’Omo, I conquistatori del Gran Sasso, edito da CDA & Vivalda, pagg. 271, da pochi mesi in libreria al prezzo di 16,00 euro.
L’autore, giornalista parlamentare dell’Ansa, è originario di Montereale e da sempre ama le altitudini e i grandi spazi delle nostre montagne, dove si rifugia appena il lavoro glielo consente.
Da questa passione per la montagna e da una spiccata attitudine a raccontare storie è nato un libro, prezioso e avvincente, dedicato alla sola montagna degli Appennini che possa essere confrontata, per maestosità e asprezza, con le cime delle Alpi.
Il libro traccia una storia, puntuale e interessante, dell’alpinismo che ha avuto come teatro le pareti del massiccio abruzzese. Su questo santuario montano nel cuore dell’Italia, frequentato nel medioevo dagli eremiti e da sempre popolato da pastori dalla pelle ruvida, tanti uomini coraggiosi hanno intrapreso scalate avventurose dal sapore epico e dall’ esito talvolta tragico.
Marco Dell’Omo, con una paziente e attenta indagine, ha raccolto documenti e testimonianze su fatti e uomini straordinari che hanno scritto la storia del Gran Sasso.
Nelle vicende, raccontate con intensità e ironia, ci si imbatte in personaggi di vario genere – scienziati, rivoluzionari, mistici – tutti fortissimi alpinisti, talvolta dotati di attrezzature approssimative e di tecniche originali. Per questo i “gransassisti” sono piuttosto degli antieroi, spesso cittadini, arrivati all’alpinismo per vie traverse, e che hanno portato in parete le loro curiosità, il loro stile di vita, i loro ideali.
Merito dell’autore è aver dato visibilità a questi uomini, le cui imprese e la cui passione sono ora uscite – grazie a questo libro - dall’ombra e dall’oblio.
|
|
| |
|
|
Cespugli di more
Presso la curva di Porta Marana, la roccia a lato della strada è rivestita di bassi e antichi cespugli. D’estate quel groviglio di rami lunghi e spinosi si popola di more, dapprima verdi, quindi, con l’avanzare della stagione, sempre più rosse.
Ogni volta che passo davanti a quei cespugli mi tornano in mente le giornate estive dell’adolescenza, quando in gruppo ci recavamo là per raccogliere i frutti maturi.
Ancora oggi, sostando in quel luogo, sento intorno a me la presenza dei miei coetanei, le loro voci, la nostra gioia mentre strappiamo dalla pianta quei frutti semplici e prelibati. Rivedo i volti dei cuginetti, le loro espressioni felici. E, soprattutto, sento il calore del sole di settembre, l’aria serena di quel mese che allora era un mese vero di vacanza come luglio e agosto.
“Certi colloqui remoti si rapprendono e concretano nel tempo in figure naturali” scrive Cesare Pavese in una delle pagine più belle di Feria d’agosto.
E’ vero, ci sono figure – un campo, una roccia, un albero – nei quali il tempo si è fermato e che ritroviamo intatto ogni volta che ci passiamo davanti.
Queste figure ci parlano e noi, contemplandole, non dobbiamo far altro che ascoltarle e lasciarle entrare in noi stessi.
Così, a poco a poco, rivivono le immagini e i suoni che quei luoghi incarnano. Rivediamo i ragazzi che eravamo, sentiamo sulla pelle l’aria di allora.
Ogni luogo della memoria ha una stagione. La stagione di quei cespugli di more è l’estate, l’estate inoltrata di settembre, quando le ore si riempivano degli ultimi giochi prima della riapertura delle scuole. Erano giornate ancora calde e luminose. Ma poi, verso sera, una brezza fresca e leggera portava già dentro di noi il sentimento dell’autunno.
|
|
| |
|
|
Profumi d'estate
Se è vero, come afferma qualcuno, che oltre all’alto mare e all’alta montagna, esiste anche l’alta campagna, questa si percepisce attraversando a piedi o in bicicletta la pianura che cinge il colle di Montereale.
All’inizio dell’estate i campi della nostra valle raggiungono l’apice della loro bellezza, pieni dei colori dal verde dell’erba al giallo delle piantagioni di cereali smosse dal vento, che soffia a tratti, come fossero onde del mare. Molti prati sono già costellati dei covoni di fieno tagliato e arrotolato, in attesa di essere portato al riparo.
Nel percorrere le strade interpoderali che si estendono nella campagna, il nostro corpo è investito dal calore e dagli odori che emanano dal sole e dalla terra.
Luce, profumi e suoni di campagna rigenerano il fisico e lo spirito. Come sono lontani, da qui, i problemi del mondo e della vita in città; come sono vive le lunghe giornate estive della giovinezza in cui s’ingannava il tempo girovagando in bicicletta fino al fiume o al campo di calcio.
L’estate può essere una spiaggia assolata o un viaggio in luoghi lontani; per me l’estate è soprattutto il profumo del fieno che sale dalla nostra campagna.
|
|
| |
|
|
Viaggio in Tunisia
E’ stato come fare un viaggio al confine tra il Nord e il Sud del mondo. Nella settimana che ho trascorso in Tunisia, attraversandola da nord a sud, mi sono chiesto più volte se mi trovassi in un’appendice dell’Europa o sull’orlo dell’Africa.
Sulla carta geografica la Tunisia appare come una penisola protesa verso la Sicilia, ma con i piedi immersi nel deserto africano.
Viaggiando verso sud il paesaggio progressivamente cambia, la vegetazione si fa più rada e la terra più brulla. Dalle fertili campagne dominate dall’ulivo si arriva infine, dopo centinaia di chilometri, alle distese di sabbia punteggiate di oasi di palme.
Il deserto è un’esperienza emozionante. Le dune sono composte di sabbia che sembra farina, si sbriciola al tatto. E’ come un liquido nel quale affondare mani e piedi.
Laggiù, ai confini con l’Algeria, l’Europa è assai lontana. Ma mi ha colpito trovare anche nei paesi sperduti dell’entroterra e nelle zone desertiche bottiglie e buste di plastica abbandonate ovunque. Per quanto tempo continueremo a inquinare il mondo?
Ovviamente il tenore di vita è inferiore a quello europeo. Nei paesi dell’entroterra è molto diffuso un animale un tempo fondamentale nella nostra agricoltura, l’asino. La gente sembra accontentarsi di poco, appare spesso indolente, ma comunque rispettosa.
Sulla costa settentrionale, tra i resti dell’antica città punica di Kerkouan, posta su uno sperone di roccia sul mare a poco più di cento chilometri dalla Sicilia, si avverte che il Mare Mediterraneo più che dividere, unisce Paesi, mette in comunicazione genti diverse, le cui storie e culture si intersecano e si sovrappongono nei secoli l’una all’altra.
Braudel dice che le civiltà non sono mortali, ma che sopravvivono a metamorfosi e catastrofi, e all’occorrenza risorgono dalle proprie ceneri; distrutte, o almeno danneggiate, rispuntano come la gramigna. Mi chiedo, allora, che cosa sia rimasto dell’antica civiltà punica. I navigatori fenici giunti dal Libano posero in Tunisia, a metà esatta del bacino mediterraneo, le basi di una nuova civiltà che viveva di scambi e traffici con la Spagna, la Sardegna, l’Italia.
Dopo la distruzione di Cartagine, fiorì la civiltà romana (di cui restano magnifici mosaici conservati al Museo del Bardo a Tunisi), poi il cristianesimo. Quindi, nel settimo secolo dopo Cristo, l’invasione araba portò in tutto il Nord Africa lingua, religione e cultura nuove che soppiantarono le altre, compresa quella berbera. La cultura araba appare oggi prevalente. Il colonialismo francese, durato fino agli anni Cinquanta, ha inciso sulla struttura amministrativa, politica ed economica di questa fetta d’Africa. Ma l’anima del popolo sembra essere araba. E’ bene conoscerla per proseguire un dialogo tra culture diverse che dura da millenni e che non deve svolgersi all’insegna della diffidenza.
|
|
| |
|
|
Colomba
L'Abruzzo è il protagonista di "Colomba", l'ultimo romanzo di Dacia Maraini. La storia narra di una ragazza, Colomba, scomparsa misteriosamente dalla sua casa, in un paese dell'Abruzzo, e di sua nonna Zaira, l'unica a non aver perso la speranza di ritrovarla e che continua a cercarla passando al setaccio i boschi delle montagne vicine. La storia di Colomba non può essere compresa senza ripercorrere le vicende drammatiche della sua famiglia dall'Ottocento ad oggi. Così nel libro incotriamo tanti personaggi, soprattutto donne, di generazioni diverse, ma legate tra loro da un destino comune di solitudine e sofferenza.
Il racconto d questa saga familiare procede tra frequenti excursus che toccano ricordi personali della scrittrice, la storia dell'Abruzzo, riflessioni esistenziali.
L'Abruzzo è presente anzitutto nel linguaggio (i dialoghi si svolgono in prevalenza nel dialetto locale), ma soprattutto nella potenza magica della natura. La narratrice resta incantata alla vista dei boschi, di quei "faggeti selvatici dove non succede niente se non piccoli incontri con volpi, lepri, cinghialetti spaventati (...) ma dove la fantasia si gonfia come un pavone in amore e costruisce case stregate, sentieri bugiardi, visioni notturne e grotte segrete. (...) Nei boschi non si è mai soli; (...) in quell'intrico di alberi ... qualcosa ci sorprenderà, ci pizzicherà il cuore, o ci riempirà l'anima di un liquido nero e misterioso.Il bosco è una città, con i suoi milioni di abitanti, che però sono invisibili e sotterranei.Perciò ci inquieta...".
La simbiosi della scrittrice con l'Abruzzo si esprime anche nella rievocazione di popoli ed eventi della nostra stora millenaria. I venti della memoria portano storie degli antichi guerrieri marsi o peligni fino a quelle dei briganti dell'Ottocento e alle vicende dell'ultima guerra.
Volgiamo credere che il successo di pubblico di quest'opera sia dovuto non solo alla sensibilità artistica della Maraini e alle storie che racconta, ma anche al fascino e alla bellezza arcana della terra in cui il romanzo è ambientato, al senso di mistero che evocano le nostre montagne, alla ricchezza di vita e di umanità che esse racchiudono. |
|
| |
|